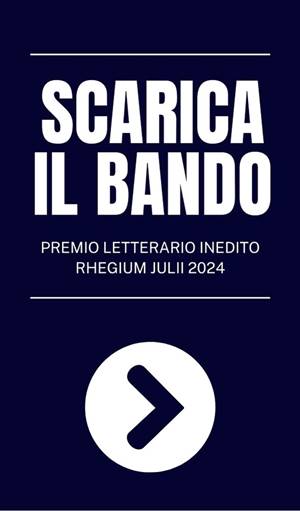- Dettagli
- Scritto da Natale Pace
- Categoria: Carta bianca
di Natale Pace
Attilio Scarcella, docente di filosofia, assessore alla cultura nel comune di Palmi negli anni Novanta, si è occupato di problematiche scolastiche e giovanili, prestando la propria consulenza al Senato della repubblica. Con L’anello che non tiene si è aggiudicato il Premio internazionale Cinque Terre 2014 e il Premio speciale della Giuria internazionale Città di Cattolica 2014.
Campo dei Fiori
di Attilio Scarcella
“Giovedì mattina in Campo di Fiore fu abbrugiato vivo
quello scelerato frate domenichino di Nola,
heretico ostinatissimo, et havendo di suo capriccio
formati diversi dogmi contro nostra fede,
et in particolare contro la Santissima Vergine et Santi,
lo scelerato volse ostinatamente morir in quelli;
diceva che moriva martire et volentieri,
et che se ne sarebbe la sua anima ascesa
con quel fumo in paradiso”
(Avviso al popolo di Roma due giorni dopo)
Campo dei Fiori,
mercoledì delle Ceneri 17 febbraio 2021,
aspettiamo Francesca al ristorante e non arriva.
- Dettagli
- Scritto da Benedetta Borrata
- Categoria: Carta bianca
di Benedetta Borrata
Lo storico Giovanni Villani narra nella sua Nuova Cronica, (IX, 136) che Dante morì a Ravenna il primo luglio del 1321 <essendo tornato da ambasceria da Venegia in servigio dei signori da Polenta, con cui dimorava; e in Ravenna dinanzi alla porta della chiesa maggiore fu seppellito a grande onore, in abito di poeta e di grande filosafo.>
La chiesa maggiore è quella dei Frati Minori francescani e la data del primo luglio è corretta dai Boccaccio in 14 settembre, la più accreditata dai dantisti.
Dopo il faticoso viaggio da Venezia, tra paludi e miasmi fangosi, il poeta giunge a Ravenna tremante per la febbre, la febbre malarica, e in breve tempo muore, in esilio, all'età di 56 anni, assistito dai figli Pietro, Jacopo e Antonia. Scrive Boccaccio: <…al suo Creatore rendè il faticato spirito; il quale non dubito che ricevuto non fosse nelle braccia della sua nobilissima Beatrice, con la quale nel cospetto di Colui ch'è sommo bene, lasciate le miserie della presente vita, ora lietissimamente vive in quella...>. (G. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, I Red., 86)
- Dettagli
- Scritto da Anna Foti
- Categoria: Carta bianca
di Anna Foti
Nella mia giovinezza ho navigato
lungo le coste dalmate. Isolotti
a fior d'onda emergevano, ove raro
un uccello sostava intento a prede,
coperti d'alghe, scivolosi, al sole
belli come smeraldi. Quando l'alta
marea e la notte li annullava, vele
sottovento sbandavano più al largo,
per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno
è quella terra di nessuno. Il porto
accende ad altri i suoi lumi; me al largo
sospinge ancora il non domato spirito,
e della vita il doloroso amore.
Tra nostalgia e dramma si stagliano nel cielo della Storia questi versi di "Ulisse" di Umberto Saba. Il poeta triestino conobbe la persecuzione, in quanto figlio di madre ebrea nell'Italia delle leggi razziali, l'esilio dall'Italia e il ritorno nella sua Trieste.
- Dettagli
- Scritto da Anna Foti
- Categoria: Carta bianca
di Anna Foti
“A voi fieri calabresi
che accoglieste ospitali me straniero
nelle ricerche e indagini
infaticabilmente cooperando
alla raccolta di questi materiali
dedico questo libro
che chiude nelle pagine
il tesoro di vita
del vostro nobile linguaggio”
Le parole possono resistere come segni di identità di un popolo anche quando tutto intorno invoca morte, distruzione e violenza; gli idiomi tratteggiano la ricchezza di un paese anche dentro un campo di prigionia che, pur togliendo la libertà di azione non sopprime il pensiero, il lingua e la cultura, spesso scrigni millenari di laboriose comunità. Lo ha scoperto e non lo ha più dimenticato, il giovane soldato tedesco Gerhard Rohlfs (Berlino 1892 – Tubinga 1986) che, durante la Prima guerra mondiale, nelle persone che ha incontrato in Italia, ha conosciuto ed esplorato un Paese ricco di dialetti e lingue antiche. Un’esperienza di tale intensità ispirazione per i suoi studi che, dopo la guerra, lasciò la Botanica per abbracciare la Glottologia.