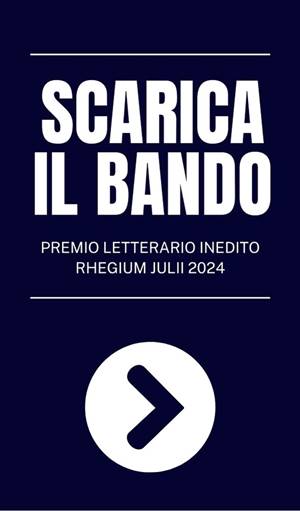- Dettagli
- Scritto da Anna Foti
- Categoria: Carta bianca
 di Anna Foti
di Anna Foti
La forza della parola scritta e fermata sotto le bombe e gli spari, oltre il filo spinato di un campo di internamento, nella penombra di un nascondiglio o nella città militarmente occupata; parole capaci di diventare semi di memoria e intensa testimonianza contro l’oblio e l’indifferenza. Parole che "dicendo" fanno in modo che ciò che custodiscono non possa essere cancellato o rinnegato, non possa essere dimenticato. Intense voci nella Storia e della Storia, queste giovani donne sono ancora un grande esempio di coraggio e tenacia e un prezioso monito di resistenza alla forza cieca della violenza che avrebbe voluto annientarle completamente, alla macchina inarrestabile di sterminio che ebbe un consenso largo, colpevole, ingiustificabile.
La scrittura sublima l'essenza di un'umanità perduta, smarrita e riscatta quella oltraggiata dalla sua stessa aberrazione e dall’odio razzista ed etnico, alimentando il diritto al sogno di un futuro. Una trama di parole che si intrecciano con la Storia, raccontano l’Olocausto e anche altri drammi come quello della guerra nei Balcani. Uno scrigno di ricordi e sentimenti che sfidano il tempo e che, grazie ai legami familiari, di amore e di amicizia che ci arricchiscono in vita e oltre, invece di andare dispersi nelle pieghe del tempo e di soccombere alla furia distruttiva della guerra, vengono salvati, custoditi e poi donati a tutti noi che abbiamo il dovere civile di accoglierli e custodirli a nostra volta.
- Dettagli
- Scritto da Natale Pace
- Categoria: Carta bianca
 di Natale Pace
di Natale Pace
119 anni fa, come oggi, nasceva il filosofo palmese Domenico Antonio Cardone. Ho avuto il privilegio di frequentarlo nella sua casa di Palmi, in via Cesare Battisti, negli ultimi anni della sua vita, in certi pomeriggi di arricchimento (per me) umano, poetico, filosofico. Parlavamo molto di poesia, io leggevo le sue di "Ritmi Astrali" e "Ritmi del Silenzio", lui leggeva le mie, prime, giovanili. Conservo gelosamente una lettera dattiloscritta con inchiostro rosso (con la macchina da scrivere) nella quale elogia le mie composizioni giovanili del primo libro "La terra ed altre canzoni" e del secondo "Il seme sotto la neve". Voglio ricordarlo con quella che probabilmente è l'ultima intervista che egli ha rilasciato e da me pubblicata in diverse occasioni su alter riviste con il suo consenso.
Buon compleanno in cielo, avvocato!
21 gennaio 2021
- Dettagli
- Scritto da Anna Foti
- Categoria: Carta bianca
 di Anna Foti
di Anna Foti
"Appresi, qualche tempo fa, che anche in Calabria funzionò, durante l'ultima guerra, un campo di concentramento per ebrei. Strano che il fatto non fosse di conoscenza comune e che le notizie ricevute fossero vaghe e confuse. Ne parlai e a Natalia Ginzburg, credendo di rivelarle cosa che potesse ignorare; ma ella era informata di tutto. Sapeva che nessuno degli internati era stato ucciso né era stato seviziato in emulazione coi lager tedeschi. E' stato anzi un campo speciale, distintosi per umanità di trattamento sugli altri costruiti in Italia. Trattenne fino a 1500 ebrei , prevalentemente fuggiti dai paesi d'Europa dove si era esteso il regime nazista, oltre un numero notevole di stranieri sorpresi dalla guerra in Italia e ritenuti , per gli indizi più vaghi, antifascisti. Il campo si chiamava Ferramonti, ed ancora il luogo è così designato. Trovasi presso Tarsia, in provincia di Cosenza, nella valle del Crati, sulla linea ferroviaria Sibari/Cosenza, ed è situato più lungo il versante tirrenico , che in quello ionico", scriveva così lo scrittore calabrese Mario La Cava in un articolo sul campo di Ferramonti di Tarsia, pubblicato sul Corriere della Sera nel 1984 e riproposto nel 2011 dal Quotidiano della Calabria in occasione della Giornata della Memoria.
- Dettagli
- Scritto da Natale Pace
- Categoria: Carta bianca
 di Natale Pace
di Natale Pace
“… Mostra il non-sense cui gli uomini si condannano attraverso il proprio linguaggio vuoto, sciocco, o a volte mostruoso, e lo fa per scolpire un nuovo linguaggio, pregno, scandito, completamente vero, tutto in bilico nel nulla, però mai di quel nulla partecipe, impossibilitato a precipitarvi, acrobata sulla propria sottigliezza, sul patto che ha stabilito col lettore, con la letteratura, con la propria storia … le parole ci servono per costruirci, costruire a noi stessi, case: parole che corrodono…” (Marco Bruno – Ewa Lipska, la discreta amante delle parole – su Poesia n.349)
Per aprire la “mia” riflessione su René Corona (mia nel senso che a sbagliare si fa sempre in tempo e me ne assumo ogni relativa responsabilità), prendo a prestito il bellissimo studio di Marco Bruno sulla poesia di Ewa Lipska, polacca di Cracovia, pubblicato qualche mese fa dalla rivista Poesia.
Ma perché tale io vedo (e leggo) René Corona: un irruento costruttore di parole. René Corona è un acrobata che ha un senso solo lassù, sospeso nelle altezze; a vederlo sulla terraferma, come dice una famosa canzonetta, ti sembra un essere senza senso. A parlarci ti ritrovi dentro le forme amorfe, tra le miscele di colori di un quadro di Vasilij Vasil'evič Kandinskij, come in un labirinto dentro il quale ti crogioli, ci stai divinamente bene e non ti passa neppure per l’anticamera del cervello di cercare la via di uscita.