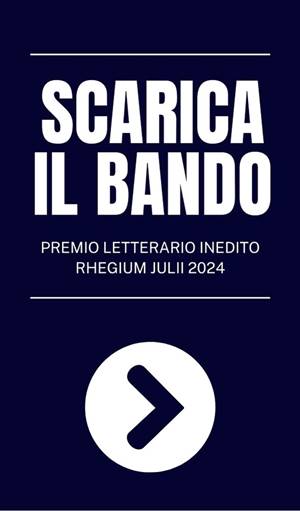- Dettagli
- Scritto da Anna Foti
- Categoria: Carta bianca
 di Anna Foti
di Anna Foti
"Sono andato al parco, quella sera, perché volevo fare una cosa per me. Ma siccome non era questo il mio destino è successo che ho fatto una cosa per tutti". Così Giuseppe - come riportato nel volume "Muori cornuto. Giuseppe Zangara, l'uomo che tentò di uccidere il presidente Roosevelt" di Arcangelo Badolati e Peppino Mazzotta, stasera al centro della conversazione in programma alle ore 21:30 al circolo Polimeni di Reggio Calabria, nell'ambito dei Caffè Letterari del Rhegium Julii - risponde all'agente che lo interroga nel tentativo di trovare prove circa la presenza di altri complici e di un complotto criminale contro la civile società Americana. Quella stessa che nel secolo scorso consentì di oltrepassare le sue frontiere a tanti poveri emigranti italiani, e soprattutto meridionale, per poi sfruttarli, maltrattarli, relegarli ai margini, discriminarli, tradendo il sogno americano di un riscatto negato in Patria e da conquistare Oltreceano, seppur con fatica, ma con dignità.
- Dettagli
- Scritto da Anna Foti
- Categoria: Carta bianca
 di Anna Foti
di Anna Foti
Alle pendici occidentali dell’Etna, nell'attuale città metropolitana di Catania, una cittadina di quasi venti mila abitanti, Bronte, nota per il suo pregiato pistacchio, in epoca risorgimentale al tempo del Regno delle Due Sicilie, fu teatro di una rivolta sanguinosa, poi punita con fucilazioni seguite a processi sommari. Quei fatti ispirarono la novella “Libertà” (da “Novelle Rusticane”) di Giovanni Verga, la raccolta di saggi “La corda pazza” di Leonardo Sciascia e il film, diretto nel 1972 da Florestano Vancini, intitolato proprio “Bronte. Cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato”. Lo stesso Leonardo Sciascia contribuì alla sceneggiatura, dedicata ai Fatti di Bronte e a quei primi ardenti dieci giorni di agosto del 1860.
Bronte fu anche sede del ducato dell’ammiraglio britannico Nelson per il quale ebbe tale ammirazione, da acquisirlo come proprio cognome, il reverendo irlandese Patrick Prunty (o Brunty), padre di tre donne scrittrici, l’unico caso della letteratura mondiale, le sorelle Charlotte, Emily e Anne, tutte morte intorno all’età di trenta anni, tutte e tre autrici di romanzi riconosciuti come eterni capolavori di letteratura inglese e opere intramontabili di narrativa romantica.
Il segno diacritico, detto dieresi, sul grafema ‘e’, finale di parola, consentì di mantenere il suono della stessa vocale come in Italiano dal momento che, invece, nella pronuncia inglese, la stessa vocale sarebbe venuta meno. Ecco che Bronte diventò Brontë e il nome del paese siciliano si legò in modo indissolubile a quello di tre scrittrici e al contributo da loro reso alla grandezza della Letteratura di tutti i tempi.
- Dettagli
- Scritto da Anna Foti
- Categoria: Carta bianca
di Anna Foti
Non avrebbe potuto più imparare cose nuove, sorprendersi, sognare di diventare grande. Non sarebbe diventata donna, neppure adolescente, Angela che quel 2 agosto aveva quasi tre anni. Lei non sapeva, e neppure sapeva sua madre Maria, con lei in procinto di andare in vacanza sul lago di Garda, che quello sarebbe stato l'ultimo sole che le avrebbe scaldate, che la notte precedente sarebbe stata l'ultima, che non avrebbero fatto più ritorno a casa a Gricciano di Montespertoli, in provincia di Firenze. In un attimo la loro vita è stata spazzata via insieme a quella di altre ottantatre persone senza colpa alcuna. Loro erano, senza dubbio, tutti innocenti.
Una morte inaccettabile, rimasta avvolta in un mistero, o come specifica meglio Carlo Lucarelli, in un segreto che qualcuno ha conosciuto ed è morto portandoselo via e che qualcuno conosce ancora senza rivelarlo. Un segreto intrappolato nelle pieghe insondabili e inestricabili di una storia complessa che a distanza di quarant'anni ancora cela trame e orditi di respiro internazionale, lascia trapelare uno spirito cospirativo e opprimente in un'Italia attraversata da tensioni nazionali ed estere, profondamente penetrata da poteri occulti, flagellata dai cosiddetti anni di Piombo.
Angela, nel posto più sicuro che per ogni bimbo e ogni bimba è dove si trovi la sua mamma, invece è in pericolo. Maria, che pensa di vivere in un Paese libero in cui basta essere accanto alla sua piccola per proteggerla, viene tradita. Chi lo ha deciso? Chi lo ha voluto? Perché?
- Dettagli
- Scritto da Anna Foti
- Categoria: Carta bianca
 Di Anna Foti
Di Anna Foti
«Know your own happiness You want nothing but patience - or give it a more fascinating name, call it hope» (Sense and Sensibility Volume I - Chapter 19, traduzione di Giuseppe Ierolli)
«Imparate a conoscere le cose buone che avete. Non vi manca nulla se non la pazienza... o se preferite un nome più affascinante, chiamatela speranza» (Ragione e Sentimento)
Un invito a seguire il cuore, a vivere con speranza e a riconoscere ciò che di buono ci circonda, e che spesso dimostriamo di non avere la pazienza e l'umiltà di apprezzare, è quello contenuto nella citazione tratta dal romanzo "Sense and Sensibility" ("Ragione e sentimento") - il titolo originario era "Elinor and Marianne" - il primo romanzo ad essere scritto (1795) e ad essere pubblicato con lo pseudonimo By a Lady (1811), dalla scrittrice britannica Jane Austen. Questa citazione è stata scelta per il memorial eretto di fronte al numero 8 di College street a Winchester, nell'Inghilterra meridionale.
In quell'abitazione, a soli 41 anni, Jane Austen, nata nel 1775 a Steventon, paesino di campagna della contea dell'Hampshire, morì tra le braccia della devota sorella Cassandra il 18 luglio 1817. La causa fu una malattia all'epoca avvolta nel mistero, accreditata in seguito come morbo di Addison e successivamente tornata protagonista anche di altre ipotesi.